Ero una bambina qualunque, viziata come io vizio ora i miei nipoti, che a 8 anni si sentì dire che era stata espulsa da scuola e che non poteva frequentare la terza elementare. Mi chiesi perché con gli occhi pieni di lacrime, e ancora oggi non ho trovato risposta. Casa mia diventò improvvisamente triste, e ricordo i poliziotti che entravano prepotentemente per controllarci i documenti. Ci trattavano da nemici della patria, la cui unica colpa era quella di essere nati. Allo scoppio della guerra la mia famiglia si trasferì in un paesello della Brianza, dove ero l’unica che non andava a scuola, e allora io dicevo che dovevo occuparmi di mio nonno, malato di Parkinson. Amavo stare con lui. Dopo l’8 settembre 1943 mio padre tentò di nascondermi da alcuni amici, anche se io non volevo abbandonare la mia famiglia e non ero grata a chi cercava di nascondermi, lo sono diventata dopo. Mio padre provò a portarmi in Svizzera, ma un ufficiale svizzero-tedesco ci disse che eravamo persone infime e ci riportò al confine, dove fummo arrestati. Come entra una tredicenne in carcere? Piangevo, e mi chiedevo il perché.
Il 30 gennaio 1944 lasciammo il carcere di San Vittore: su quel trasporto partito dal binario 21 della stazione centrale di Milano fummo in 605 e tornammo in 22. Ci caricarono su un carro bestiame, senza luce, senz’acqua, solamente con un secchio. Eravamo 40-50 persone in ogni vagone e c’era odore di urina, paura e morte. Il viaggio durò una settimana e sviluppò in tre fasi: inizialmente piangevano tutti; in una seconda fase gli uomini religiosi iniziavano a radunarsi per lodare Dio, ma negli ultimi due giorni ci fu un silenzio essenziale, di quando si sta per morire. Arrivati ad Auschwitz il silenzio si contrappose ai tanti rumori e iniziò la grande selezione della Shoah, che non fu una cosa istintiva ma programmata da anni. Dopo la separazione fra uomini e donne, ci dissero che dopo la registrazione ci saremmo ritrovati. Invece fummo selezionati, di quelle 605 persone selezionarono 31 donne e una settantina di uomini. Quando entrai nel campo di Birkenau-Auschwitz e vidi il crematorio, le baracche e le persone scheletrite pensavo di essere in un incubo. Lavorai da schiava-operaia in una fabbrica di munizioni, ma fu una fortuna lavorare al coperto in quegli inverni e superai tre selezioni, nell’anno che rimasi ad Auschwitz. I Kapo, dopo averti denudato, controllavano le tue condizioni ed eri grata al tuo assassino quando ti lasciava in vita. In fabbrica lavoravo come inserviente di Jeanine, una ragazza francese. Due giorni prima della selezione un macchinario le tranciò due dita, mentre io mi rivestivo felice sentii che la fermarono dietro di me. Non mi sono voltata, non le ho fatto coraggio, non l’ho salutata e il giorno dopo al suo posto c’era un altra persona. I miei assassini erano riusciti a farmi diventare una lupa affamata ed egoista. Fui orribile, vigliacca. Ho fatto la marcia della morte senza sapere dove fossi. Dopo l’ho vista sulla carta geografica, ma allora non sapevo. Camminavo, vedevo nomi che non mi dicevano niente, che dimenticavo subito dopo aver letto. Migliaia e migliaia di esseri stremati che si trascinavano nella neve come automi. La strada disseminata di cadaveri, donne, uomini morti per lo sfinimento, per il freddo, o finiti dai soldati della scorta con una fucilata alla testa. Io non li guardavo, andavo avanti, un passo dopo l’altro, come ubriaca, perché volevo vivere, non volevo morire. Come le altre mi gettavo sugli immondezzai nella speranza di racimolare un torsolo di cavolo, una buccia di patata, una cosa qualsiasi da rosicchiare. Era una follia. Anche voler vivere era una follia. Avevamo già perso da mesi i freni inibitori. Se avevi un bisogno fisico, poteva esserci chiunque davanti a te, ti accovacciavi al bordo della strada, facevi quello che dovevi fare e proseguivi. Ero già prigioniera da un anno, e un anno ad Auschwitz ti cambia enormemente. Camminavamo, nevicava, ricordo come dei flash, però non una continuità. Non saprei dire né quanti giorni né quante notti sia durata. La prima volta che ci siamo fermate eravamo in una stazione bombardata, il tetto mezzo aperto. Eravamo in cinquantaseimila a fare la marcia della morte. Questo l’ho letto poi, perché certo allora non lo sapevo. Ci facevano camminare soprattutto di notte, perché i civili non dovevano vederci. Quando passavamo nei paesi c’era l’oscuramento, la gente doveva tenere le finestre chiuse, le porte chiuse.Poi mi ricordo che abbiamo percorso un tratto su un treno merci, con i vagoni scoperti, sotto la neve che fioccava, pigiate l’una contro l’altra, e alla mattina ci scrollavamo di dosso i cadaveri, tutti coperti da un sottile strato di ghiaccio. Essere pressate, per quanto orribile, ci ha salvato, perché il corpo umano emana un certo calore, altrimenti saremmo morte assiderate. Tutte, alla mattina, avevamo una crosticina di ghiaccio sopra alle divise, e poi c’erano quelle dure, morte. Siamo scese saltando giù da questo vagone, contente di aver fatto un pezzo col treno e non a piedi. Mi chiedevo come Liliana avesse fatto a macinare tutti quei chilometri. Ragazzi, non dite mai che non ce la fate più, non è vero. Siamo fortissimi e dobbiamo trasformare la marcia della morte nella marcia della vita, che potete plasmare per gran parte con le vostre mani. Abbiate coraggio e orgoglio di come siete senza ascoltare i bulli, chi fa il bullo è quello che da grande può fare il Kapo, hanno la stessa consistenza. Sono i più fragili che hanno bisogno di dire che sono forti, i forti non ne hanno bisogno.
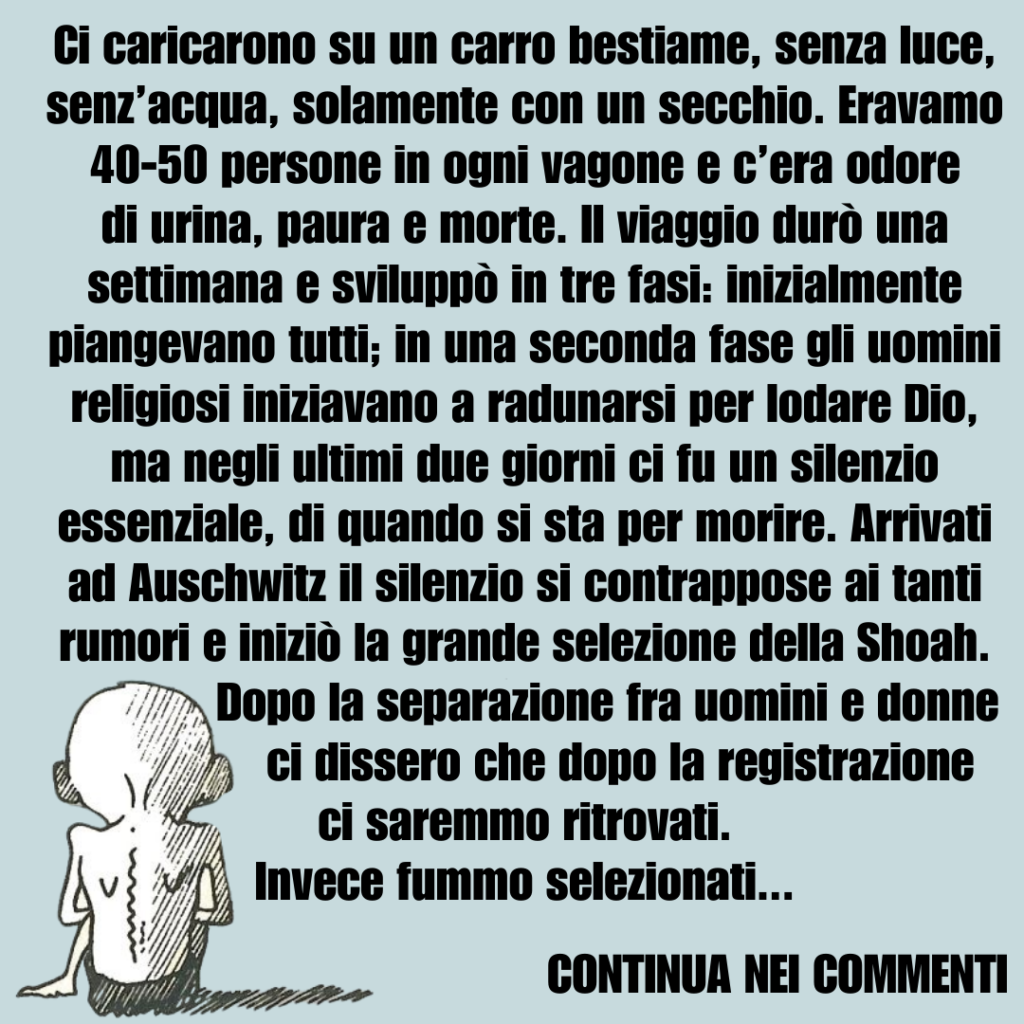
Tratto dalle testimonianze di Liliana Segre, sopravvissuta al campo di concentramento. Venne liberata il 1º maggio 1945 dal campo di Malchow, un sottocampo del campo di concentramento di Ravensbrück che fu liberato dall’Armata Rossa. Dei 776 bambini italiani di età inferiore ai 14 anni che furono deportati ad Auschwitz, Liliana fu tra i 25 sopravvissuti.