In Aurora Giorgio Nisini riprende la struttura della fiaba La Bella Addormentata nel bosco trasfigurando e attualizzando situazioni e personaggi, fino a tessere un avvincente intreccio narrativo che possiede tutte le caratteristiche di un godibilissimo romanzo dai tratti noir.
Pur guardando alla tradizione della celebre fiaba nelle sue diverse varianti – dalla perturbante versione barocca di Giambattista Basile alla riscrittura di Charles Perrault, dall’incantevole Rosaspina dei fratelli Grimm fino all’operazione letteraria di Italo Calvino in “Fiabe Italiane” – con cui la storia della bella principessa è penetrata attraverso i secoli nell’immaginario collettivo europeo fino a fissarsi in modo indelebile con l’iconografia pop della Disney, l’autore crea infatti una narrazione autonoma, in cui si muovono personaggi a tutto tondo, lontani dunque dello stereotipo bidimensionale della figurina disneyana e dotati semmai di una personalità complessa e, soprattutto, estremamente moderna.
A guardar bene, i possibili ingredienti della grande fiaba ci sono davvero tutti: un re e una regina che attendono con ansia un erede e lo ottengono soltanto dopo molte peripezie, una principessa vittima di un sortilegio a causa del quale sprofonda in un misterioso letargo, una strega orrida e vendicativa, un castello cadente in attesa di essere avvolto dalla luce, uno stravagante mago disponibile ad aiutare la coppia reale e infine, ma non certo per importanza, un principe azzurro innamorato.

Come per il potere di un incantesimo, ciascuno di questi elementi assume però qui le luci e le ombre della modernità borghese che caratterizza la provincia italiana: Aurora, la bella addormentata, è infatti un’adolescente che trascorre il suo tempo sui social e si innamora del bulletto narciso e inconsistente della scuola; mentre l’imprenditore Stefano e la moglie-madre Carola – a rappresentare la fiabesca coppia reale – si distinguono per l’ambivalenza delle emozioni e la complessità dei vissuti interiori, pronti ad esplodere quando la loro rassicurante vita borghese viene alterata dall’irrompere improvviso dell’elemento incomprensibile in grado di scardinare ogni certezza: la narcolessia, inspiegabile alla razionalità della scienza, in cui Aurora precipita appena tocca la soglia della femminilità.
Ecco allora che la fiaba si tinge di nero, con telefonate anonime nel cuore della notte in grado di aprire a Stefano e a Carola interrogativi sospesi, sullo sfondo di una fabbrica dismessa che nasconde chissà quali scheletri, fino a rievocare un misterioso suicidio che implora vendetta dal passato dell’azienda di famiglia, gli Orsini Gianotti, le cui origini aristocratiche si intrecciano alle sorti della fabbrica di lampadine Fulgor – emblema della vivacità imprenditoriale della provincia italiana del Novecento – e di cui Stefano, ultimo erede, è proprietario e dirigente illuminato.
E come in ogni fiaba della tradizione, il mondo reale incontra il mondo degli ultimi: vi appartengono il mago Isidoro Pellagra, ritratto in un vivido affresco paesano rafforzato dal ricorso al dialetto; la strega, a sua volta vittima pervasa in ogni sua apparizione di cieca invidia sociale, e – qui è l’inedito – lo stesso principe azzurro.
Filippo infatti, lontano dallo stereotipo del giovane ricchissimo e bellissimo, è qui un uomo dalle origini oscure, con zone d’ombra che si alternano a una apparente trasparenza dei sentimenti in cui, nei non detti della narrazione, si percepisce però un fondo torbido. La dimensione arcana che unisce Filippo e Aurora sembra infatti calamitare i protagonisti in uno spazio “altro”, sospeso tra l’universo magico – fantastico della fiaba e l’insondabile mondo oscuro di junghiana memoria, denso di archetipi e dimensioni dell’inconscio, che sembrano obbedire a ragioni tanto profonde e ancestrali da risultare assolutamente imperscrutabili.
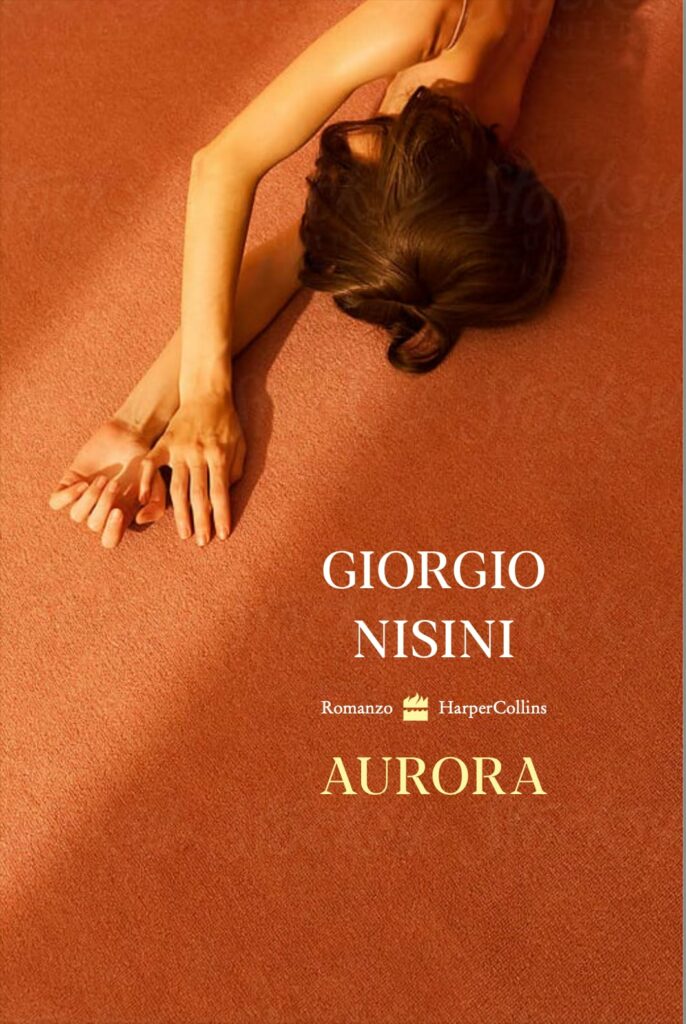
Con il procedere delle pagine, Il lettore non può non affezionarsi ai destini dei personaggi che, sebbene rispettando lo schema narrativo della fiaba, promettono esiti inattesi, generando suspense e continua sorpresa. Man mano che le attese vengono scardinate nel fluire della narrazione, i protagonisti della vicenda diventano sempre più familiari: Carola in particolare è raccontata in tutta la complessità di una donna che ha trovato nel ruolo di moglie e di madre una dimensione di apparente equilibrio, nascondendo a sé stessa insoddisfazioni e inquietudini che talvolta erompono in una dimensione spirituale sospesa tra superstizione e cultura religiosa borghese benpensante. Sensi di colpa, femminilità inespressa, maternità conflittuale costituiscono il terreno in cui germoglia il non detto del matrimonio con Stefano, una unione che pure vede, davanti alla tragedia che travolge la famiglia, momenti di grande intimità emotiva.
Lo stesso Stefano, imprenditore e marito che vive nella famiglia la sua dimensione più rassicurante, è delineato in tutto il suo spessore di uomo socialmente e affettivamente “compiuto”, ma anche di padre affettuoso e apprensivo, tormentato da mille interrogativi circa il destino della propria unica e amata figlia, per la quale sogna un futuro di felicità che invece si allontana sempre di più, fino ad infrangersi davanti a un evento inatteso della vita, tanto indesiderato quanto imbarazzante.
E poi c’è Aurora precipitata in un sonno inspiegabile che si consuma in un letto d’ospedale trasmutato in bosco incantato, allegoria della sessualità scoperta, temuta, desiderata e travolgente come sempre accade nelle giovani donne. L’incontro sessuale diviene allora alchimia, arcano sortilegio con cui la strega crudele consuma una terribile vendetta, ma è anche ritorno alla vita – come ogni aurora appunto – per l’ambivalenza della forza ancestrale che lo determina, ovvero il desiderio che sconfina oltre la coscienza e la obnubila. È incontro, morte, rinascita e trasformazione: Aurora, in questo romanzo di formazione “sui generis”, si risveglia donna fino a generare nel grembo una creatura dai tratti stranianti per la vivida e prematura coscienza di sé.
Se è vero che nelle fiabe l’amore vince sempre, anche “Aurora” non fa eccezione. Se non fosse che qui l’amore non è un sentimento rassicurante e tantomeno messaggero di insegnamenti morali, bensì nasce dalla vendetta e si trasforma in vincolo fatale attraverso un oscuro rito magico.
Nessun “e vissero felici e contenti”, semmai nella conclusione assistiamo allo scioglimento dell’enigma in cui si svela la vera identità di Filippo, il principe azzurro di Aurora, il quale, in barba alle funzioni narrative di Vladimir Propp, ha ben poco dell’eroe positivo: non è giovane, non è di origini aristocratiche e non è nobile d’animo.
Il finale stesso, peraltro, apre inquietanti scenari possibili che si materializzano nella disturbante immagine dell’erede, la neonata dagli “occhi profondi e scuri” e “con un eccesso di coscienza fastidioso”, il cui futuro lascia presagire il reiterarsi di destini oscuri, pronti a consumarsi nel cuore nero della più rassicurante normalità borghese.
Cinzia Mescolini