Un’opera di grande attualità, sull’emigrazione e l’appartenenza, che offre diversi spunti per decifrare anche quanto sta accadendo dall’altra parte del mondo, in Afghanistan, dove le ragioni militari dell’Occidente si sono sgretolate davanti a una complessità che non hanno saputo interpretare né gestire: tutto questo è molto altro ancora è Elegie alla patria di Ayad Akhtar.
Nato a New York in una famiglia pakistana, Akhtar ha studiato alla Brown University e alla Columbia University, prima di trasferirsi in Italia per un anno per studiare recitazione. Nel 2012 esordì nel mondo della letteratura con il romanzo “La donna che mi insegnò il respiro”. Nel 2013 fece il suo debutto a teatro con il dramma “Disgraced”, che gli valse l’Obie Award ed il Premio Pulitzer per la drammaturgia.

Un racconto intimo sul reale valore dell’identità, sulle difficoltà di essere americano e mussulmano nel mondo post 11 settembre, ma anche la storia dell’influenza della crisi economica e della cavalcata elettorale di Trump nei rapporti tra un padre immigrato, che ama gli Stati Uniti e tutto ciò che rappresentano anche quando ciò mette in pericolo la sua stessa posizione e sicurezza, e un figlio, americano per nascita e formazione, che però inizia a dubitare dei valori con cui è cresciuto, quelli domestici, ma soprattutto quelli patriottici e consumistici tipici della sua generazione. Con un’opera che è in parte dramma familiare e in parte romanzo picaresco, Ayad Akhtar nel libro che Salman Rushdie ha definito “appassionato, inquietante e impossibile da abbandonare” offre uno sguardo attento e profondo sugli Stati Uniti e sulle loro contraddizioni, mescolando finzione e biografia racconta la storia di un padre e un figlio, dei rapporti con il passato e con le proprie radici e della necessità di affrontare i problemi che questi pongono per sentirsi bene a casa propria.
Elegie alla patria è stato uno dei libri preferiti di Barack Obama nel 2020; è stato considerato uno dei 10 migliori libri dell’anno da “The New York Times”, “Entertainment Weekly”, “The Washington Post”, “New York Times Book Review”, “Publisher Weekly”, “NPR”, “Shelf Awareness”, “St. Louis Post-Dispatch”, “Library Journal”, “The Economist” ed è stato finalista per la Andrew Carnegie Medal 2021 per il miglior romanzo.
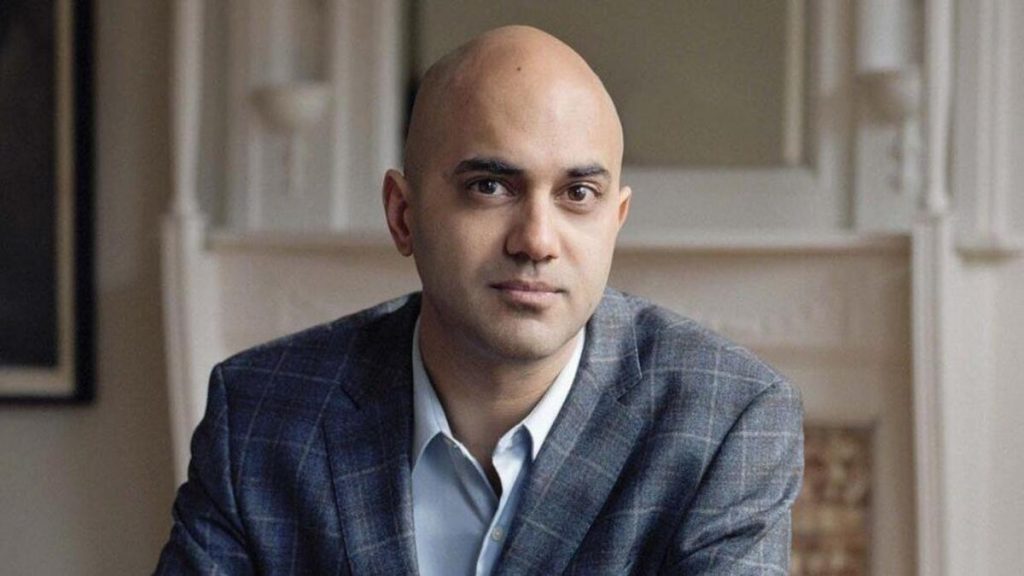
L’incipit di Elegie alla patria
Ouverture. All’America
Ho avuto una docente all’università, Mary Moroni, che insegnava Melville ed Emerson, e che il letterato un tempo famoso Norman O. Brown — suo mentore — definì la mente più acuta della sua generazione; una donna minuta poco più che trentenne con un viso da cherubino, che somigliava non a caso (i suoi genitori erano immigrati da Urbino) a un putto di Raffaello; una studiosa sorprendentemente erudita che citava con la stessa facilità le Edda, Hannah Arendt e Moby Dick; una lesbica, cosa di cui faccio cenno solo perché era lei stessa a dirlo, e spesso; un’oratrice dai giri di frase taglienti come un coltello da cucina tedesco, capace di incidere la materia grigia del cervello e aprirvi nuovi solchi lungo i quali vecchi pensieri potessero instradarsi. Come quella mattina di febbraio, due settimane dopo il primo insediamento di Bill Clinton, quando, durante una lezione sulla vita agli albori del capitalismo in America, Mary, chiaramente interrotta dai suoi stessi pensieri tentatori, alzò lo sguardo dal pavimento che d’abitudine fissava mentre parlava — la mano sinistra nascosta, come al solito, nella tasca degli ampi pantaloni casual che erano il suo pilastro –, alzò lo sguardo e osservò in maniera quasi estemporanea che l’America era nata come colonia e restava una colonia, vale a dire un luogo ancora definito dal suo saccheggio, dove arricchirsi aveva la priorità su tutto e l’ordine civile veniva sempre in secondo piano. La madrepatria in nome della quale — e a beneficio della quale — la predazione continuava non era più una madrepatria fisica, bensì spirituale: il Sé Americano. Da tempo addestrato a idolatrare i propri desideri — per quanto modesti e banali fossero — piuttosto che a metterli in discussione, come insegnava la tradizione classica, il turgido amor proprio americano, disse, era la patria della spoliazione; e gli anni di razzia del regime reaganiano avevano solo incarnato quella realtà immutabile della vita americana con maggiore chiarezza e trasparenza di quanto non fosse mai avvenuto prima.

Nel semestre precedente Mary si era messa nei guai per alcune osservazioni altrettanto stimolanti sull’egemonia americana subito dopo la guerra del Golfo. Un suo studente iscritto al programma Rotc, il Corpo di addestramento degli ufficiali di riserva, aveva presentato un reclamo all’amministrazione perché durante le lezioni teneva discorsi contro le truppe. Aveva lanciato una petizione e raccolto firme nell’associazione studentesca. Quel putiferio aveva portato a un editoriale sul giornale del campus e minacce di protesta che non si erano mai realmente concretizzate. Mary non si era lasciata intimorire. Dopotutto, erano i primi anni novanta e le conseguenze di un’eterna dannazione ideologica — o dell’abuso di potere sessuale, già che ci siamo — non erano certo quelle di oggi. Ammesso che qualcuno avesse da ridire sulle sue affermazioni di quel pomeriggio, io non ne seppi nulla. La verità, secondo me, è che molti di noi non capirono nemmeno a cosa alludesse. Io no di certo.

Culto del desiderio. Turgido amor proprio. Una colonia finalizzata al saccheggio.
Nelle sue parole c’era la forza di un grande diniego, il correttivo a una tradizione di infinito autocompiacimento americano. Era qualcosa di nuovo per me. Ero abituato all’eccezionalismo della nazione benedetta da Dio, faro del mondo, che aveva permeato ogni singola ora delle mie lezioni di storia. Ero diventato maggiorenne nell’epoca della città sul monte la cui luce splende perché tutti la vedano. Queste erano le gloriose metafore che avevo appreso a scuola, che consideravo non metafore ma verità. Vedevo una benevolenza americana nel truce sguardo d’intesa dello zio Sam all’ufficio postale; sentivo l’abbondanza americana nelle risate registrate delle sit-com che guardavo ogni sera con mia madre; provavo la sicurezza e la forza americane mentre pedalavo sulla mia Schwinn a dieci marce, sfilando davanti alle case a livelli sfalsati e a due piani nel quartiere borghese dove sono cresciuto. Naturalmente mio padre era un grande ammiratore dell’America a quel tempo. Per lui, non c’era posto più grande al mondo, nessun luogo dove si potesse fare di più, avere di più, essere di più. Non se ne stancava mai: fare campeggio sui monti Teton, attraversare in macchina la Valle della Morte, salire in cima all’arco di St. Louis prima di saltare su un battello fluviale diretto in Louisiana per pescare il branzino nel bayou. Adorava visitare i siti di interesse storico. Avevamo incorniciato le nostre foto dei viaggi a Monticello e Saratoga e alla casa di Beals Street, a Brookline, dove erano nati i fratelli Kennedy. Mi ricordo di un sabato mattina a Philadelphia, quando avevo otto anni, e mio padre mi rimproverò per avere piagnucolato durante un interminabile giro di una serie di sale che avevano qualcosa a che fare con la Costituzione. Quando fu finito, prendemmo un taxi per la famosa scalinata del museo, e mi sfidò a gara fino in cima — facendomi vincere! — in omaggio a Rocky Balboa. L’amore per l’America e una salda fede nella sua superiorità— morale, e non solo — erano in casa nostra un credo, che mia madre sapeva di non dover contestare, anche se non lo condivideva appieno. Come entrambi i genitori di Mary — lo avrei appreso in seguito dalla stessa Mary —, mia madre non trovò mai nei vari tesori del suo nuovo paese nessun risarcimento adeguato alla perdita di ciò che si era lasciata alle spalle. Non penso che mia madre si sia mai sentita a casa qui. Considerava gli americani dei materialisti e non riusciva a comprendere cosa ci fosse di così santo nell’orgia di acquisti che chiamavano Natale. La indisponeva che tutti le chiedessero sempre da dove veniva e non sembrassero mai preoccupati per il fatto che non avevano la minima idea di cosa stesse parlando quando glielo diceva. Gli americani erano ignoranti non solo in geografia, ma anche in storia. Ma la cosa più seccante di tutte per lei era qualcosa che considerava collegata a questa loro indifferenza per le cose importanti, e cioè il rifiuto degli americani di invecchiare e morire. Quest’ultimo motivo di irritazione avrebbe prodotto nel corso degli anni una concrezione maligna, una terrorizzante bête noire che finì per portarla alla tomba: il pensiero che invecchiare qui significasse per lei in ultima analisi essere segregata ed esalare l’ultimo respiro in una «casa» che non assomigliava affatto a una casa.
Elegie alla Patria
Ayad Akhtarù
La nave di Teseo


